Capire il presente ripensando la storia
Andrea Graziosi, il maggiore storico italiano dell’Unione Sovietica, ha pubblicato per l’Editore Laterza di Roma L’Ucraina e Putin tra storia e ideologia, un libro particolarmente utile, da leggere. Il saggio è costruito su due binari: da una parte la disamina dei diversi percorsi che hanno intrapreso l’Ucraina e la Russia, anche in ragione delle loro diversità, in particolare dopo la dissoluzione dell’URSS nel 1991; dall’altra l’analisi del peso dell’eredità sovietica, anche sul piano delle mentalità, e dei grandi e irrisolti problemi creati dal crollo dell’URSS. Significativa la verifica fatta dall’autore delle similitudini tra spazio ex-sovietico e spazio ex-jugoslavo (tensioni e conflitti scaturiti dalla crisi delle etno-federazioni socialiste, confini problematici, territori plurilingui e plurireligiosi). Fa tra l’altro riflettere il fatto che negli anni Novanta del secolo scorso feroci conflitti etno-nazionali esplosero nella ex-Jugoslavia ma non nello spazio ex-sovietico, dove la maggioranza dei protagonisti dell’epoca optò per scelte non violente, con “prudenza e ragionevolezza”. Ciò riconosciuto, mai venne tuttavia meno l’ambizione della Russia a essere “centro” di un suo continente/mondo/universo/impero. La brama di proiettarsi verso nuove grandezze si ammantò presto di una nuova ideologia aggressiva che attinge a vari falsi miti e coincide con l’era putiniana. Perché, al di là delle grandi forze, questa guerra è figlia di una decisione di Putin e della classe dirigente che lo attornia. Intanto, pur in maniera contradditoria e asimmetrica, l’Ucraina, dopo essere stata sovietica, cercava lentamente di darsi una propria coesione rafforzando il proprio essere comunità nazionale partendo dal dato di fatto della propria pluralità e guardando più verso i modelli occidentali che verso quelli imposti da Mosca. Mai dimenticare che etnicità, lingua e religione in Ucraina non coincidono: gli ucraini non sono russi anche se parlano russo (lingua veicolare) e possono essere di fede ortodossa.
Il grande pregio di questo libro è che per capire come si sia giunti all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (iniziata nel 2014) l’autore scava con innegabile competenza nella storia interna dell’URSS, nei meandri delle realtà post-sovietiche e negli sviluppi più recenti dello Stato russo e di quello ucraino. Da fine conoscitore della materia non si limita affatto – com’è fin troppo d’uso – a limitarsi con superficiale leggerezza a scaricare tutte le colpe di questa guerra della Russia contro l’Ucraina su Bruxelles e Washington, sull’UE e sulla NATO.
Vedi l’Indice del volume.
Dalla scheda dell’Editore: “L’invasione russa dell’Ucraina non è soltanto una tragedia, ma rischia di essere anche lo spartiacque tra due diverse fasi della storia europea. Per comprendere le cause e le ragioni di questi avvenimenti è necessario conoscere la storia dei due paesi e l’ideologia di cui sono imbevuti Putin e la sua classe dirigente”.
“Perché Putin ha pensato di poter conquistare in pochi giorni l’Ucraina con il consenso dei russi ma anche degli ucraini? Cosa vuol dire ‘denazificazione’? Per spiegare questa tragedia che cambia il mondo occorre ritornare ad alcuni passaggi essenziali della storia del Novecento prima e dopo il 1991. Una vicenda complessa, che parte dal rapporto dell’Ucraina con il potere sovietico di Lenin e che passa dall’Holodomor, la terribile carestia provocata da Stalin che nel ʼ32-ʼ33 fece in Ucraina più di quattro milioni di vittime. Una storia che continua con la Seconda guerra mondiale e l’occupazione nazista e prosegue con la fine dell’URSS e le difficoltà degli anni Novanta, cui l’Ucraina ha risposto guardando all’Unione Europea mentre in Russia si affermava la svolta autoritaria di Putin, fondata sul consenso a una ideologia di potenza radicata nella storia russa e condivisa da una classe dirigente formatasi tra declino sovietico e riaffermazione del potere dello Stato. Una ideologia che spinge Putin a disprezzare un Occidente opulento e corrotto in declino economico e demografico. E che gli fa pensare che sia arrivato il momento per ridare alla Russia il suo ruolo di grande potenza mondiale”.
Vedi il video introduttivo nel quale Andrea Graziosi racconta L’Ucraina e Putin tra storia e ideologia.
Leggi un estratto dell’Introduzione e della Nota al Lettore.
Vedi l’intervento di Andrea Graziosi a “Rebus” di Rai Tre condotto da Corrado Augias e Giorgio Zanchini.
Andrea Graziosi, professore di Storia contemporanea all’Università di Napoli Federico II, ha studiato e insegnato in università americane, russe ed europee. Tra le sue pubblicazioni, tradotte in varie lingue: Guerra e rivoluzione in Europa. 1905-1956 (2002), L’Urss di Lenin e Stalin. Storia dell’Unione Sovietica 1914-1945 (2007), L’Urss dal trionfo al degrado. Storia dell’Unione Sovietica 1945-1991 (2008) e Grandi illusioni. Ragionando sull’Italia (con Giuliano Amato, 2013) per il Mulino; Lettere da Kharkov (a cura di, Einaudi 1991); The Battle for Ukrainian. A Comparative Perspective (a cura di, con Michael S. Flier, Harvard University Press 2017); La grande guerra contadina in Urss (Officina libraria 2022); Genocide. The Power and Problems of a Concept (a cura di, con Frank E. Sysyn, McGill-Queen’s University Press 2022).
Nella sua lunga e ricca recensione al libro di Andrea Graziosi, Adriano Sofri (“Il Foglio”, 30 ottobre 2022, p. V) tocca un punto che vale la pena citare: “Benché il paragone fra la Russia degli anni ’90 e la Germania degli anni ’20 sia del tutto infondato, parte dei gruppi dirigenti russi si convinse di un’umiliazione che era solo nelle loro menti. Le idee contano: così il sogno di un nuovo Mondo Russo di Putin – anche i malvagi infatti non sono sempre cinici. Parlando della più grande catastrofe geopolitica del ventesimo secolo Putin dimenticò che Washington aveva provato fino all’ultimo a salvare l’Unione sovietica e che la Russia di Eltsin, di cui era l’erede, aveva invece giocato un ruolo cruciale nella sua dissoluzione. Alla Russia non fu imposta alcuna riparazione e non fu tolto alcun territorio. Venne ammessa nel club dei grandi, nel 1997 il G7 fu ribattezzato G8, e al suo esercito non fu imposto alcun tetto. Quanto alle proteste di Putin sull’espansione della NATO, nel 1994 la Russia ricevette, grazie al sostegno americano, le circa 4000 testate nucleari ucraine, oltre a quelle kazake, in cambio delle quali si impegnò a garantire i confini della Repubblica sorella. La storia è cruciale perché indica quali fossero i sentimenti filo-russi degli Stati Uniti negli anni ’90, rivela la malafede della Mosca odierna, e suscita amarezza in una Kyiv che si fidò allora degli impegni di russi americani e inglesi, i garanti degli accordi di Budapest”. Prosegue l’autore: “Il pericolo reale [per Putin] è quello costituito dall’Unione Europea e dalla sua cultura, contro cui la Mosca di Putin combatteva da tempo, sostenendo e finanziando i movimenti sovranisti. Putin ha giustificato l’operazione militare speciale anche con la necessità di fermare il genocidio in corso da 8 anni nel Donbass. Nella regione ci sono però dal 2014 centinaia di osservatori Osce e i loro dati parlano chiaro. Le vittime civili, di entrambe le parti, sono state 2084 nel 2014, l’anno della guerra aperta, 954 nel 2015, 112 nel 2016, 117 nel 2017, 55 nel 2018, 27 nel 2019, 26 nel 2020, e 25 nel 2021”.
Vedi anche: Mauro Gilli, Perché la narrazione di una “umiliazione” di Mosca dopo il crollo dell’Urss è surreale, “Il Foglio”, 5 marzo 2022.
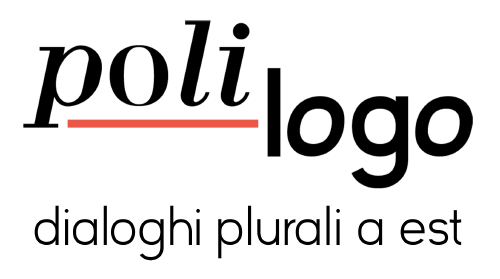

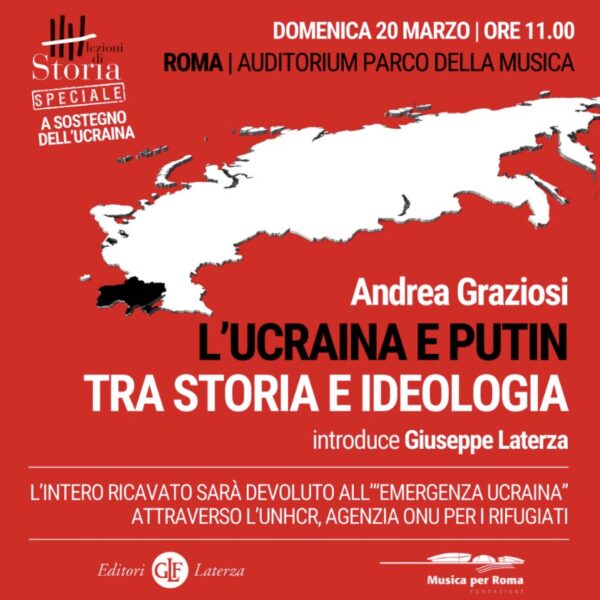
1 Commento. Nuovo commento
[…] Tra Russia e Ucraina, divergenze. Capire il presente ripensando la storia. […]