Ascoltandoli parlare e rileggendo alcuni loro saggi
di Paolo Morawski
Nessuno parla della sofferenza degli intellettuali e studiosi ucraini, quelli che sono più vicini alle agorà dell’Europa occidentale e alle università americane, che frequentano da anni i nostri paesi, le nostre istituzioni di ricerca o di alta formazione. In quanto ricercatori o visiting professor insegnano nelle nostre aule, animano seminari, scrivono sulle nostre comuni riviste specialistiche. Respirano la nostra stessa aria.
Soffrono molto questi amici e colleghi ucraini, donne e uomini. Soffrono per il loro paese che patisce la guerra di aggressione russa. Ma soffrono anche per altri motivi – e quei motivi siamo noi. Noi siamo la fonte della loro costernazione, del loro dolore, dei loro ripetuti mal di pancia. Noi italiani, noi europei dell’Ovest. Qual è la nostra colpa?
Innanzitutto, di non aver voluto vedere la realtà della Russia di Putin per quello che era, per come stava evolvendo, per come infieriva al proprio interno su chi solo osava criticare o anche disapprovare l’operato del potere (giornalisti, oppositori, nuovi “dissidenti”, personaggi o istituzioni scomode). Poi per come trattava ceceni e georgiani, ucraini e bielorussi. Da anni la Federazione Russa in linea con la sua visione neo-imperiale negava all’Ucraina il diritto a esistere al di fuori dal controllo di Mosca. Oggi le nega il diritto di esistere, di scegliere la “propria via”. Da anni gli amici ucraini cercavano di spiegarci la loro situazione, il loro punto di vista sul contesto “reale” a Est, sulla concretezza della Russia imperiale/coloniale. Invano. Le amiche e gli amici ucraini erano – sono – da noi derisi, tacciati di isterismo da guerra fredda, accusati di russofobia. Da tre mesi a questa parte qualcuno di noi ha fatto ammenda, sincera ammenda per la propria sordità e cecità? Io per primo no, mea culpa proprio no, io – io non solo ero e sono male informato, ma avevo e ho tuttora voglia di credere al lupo buono, di tapparmi le orecchie, di chiudere gli occhi, di recepire in modo selettivo a me conveniente le informazioni provenienti da Est. Avevo e ho voglia di farmi raccontare proprio “queste” belle storie, ipnotiche come ninne nanne, tanto più comode che, se sono false, non mettono in discussione la mia zona confort. Io non faccio ammenda, no, ho flirtato col mostro, col Minotauro, perché il Minotauro non si può, non si deve provocare.
Secondo motivo di sofferenza per gli intellettuali e studiosi ucraini che ci sono più vicini è che, per quanto riguarda l’Ucraina, noi continuiamo in tondo e con granitica convinzione a sposare il punto di vista russo, la visione russa, l’impostazione del discorso e gli schemi mentali russi. Sono anni che inconsapevolmente facciamo nostre le narrazioni russe, al punto che ci sembrano scontate, normali, indiscutibili. Ne siamo così acriticamente imbevuti che tutte le nostre discussioni (pro o contro) sono dentro il (manipolato) racconto russo, dentro la cornice stabilita da Mosca. È una situazione post-coloniale che va adeguatamente analizzata (ci tornerò).
Il paradosso è che siamo noi, noi italiani, a spiegare agli ucraini – noi che non abbiamo mai messo piede in Ucraina, noi che non parliamo ucraino e neppure russo – noi a spiegare agli ucraini cos’è l’Ucraina e cos’è la Russia, come l’Ucraina dovrebbe agire, fare, cosa dovrebbe dire, pensare, cosa dovrebbe cedere, a quali compromessi sottostare. Insomma siamo così convinti di ciò che prima l’URSS e poi la Russia ci hanno delicatamente e continuativamente propinato, che a nostra volta siamo diventati ambasciatori della “vera” e “ovvia” e “obiettiva” e “scientifica” narrazione russa. Tutto pare “evidente”, sebbene non lo sia affatto. Si pensi all’uso del concetto di “crisi ucraina” al quale si è fatto abbondantemente ricorso dal 2004 e poi nuovamente dal 2014. Come giustamente osservano le amiche e gli amici ucraini parlare di “crisi” significa che non c’è aggressore, l’aggressore non viene né nominato né evocato.
Capisco le pene del purgatorio che patiscono i colleghi ucraini. Non solo noi (singoli individui, istituzioni, media, accademie, testate giornalistiche, gruppi editoriali) siamo caduti in trappola (trappola culturale, ideologica, mentale), ma abbiamo una fede infantile nell’idea che tutto si aggiusta con le buone maniere, con la forza, si, ma del business, che tutto si può ragionevolmente negoziare, che noi – noi? – sapremo riportare la Russia alla ragione, basta solo che… Purtroppo, come i fatti finora dimostrano, in questo caso non è così. Ora, cosa accade se – come accade – la razionalità del potere russo-putiniano è “altra”, è “irrazionale” per taluni versi e comunque distante per non dire opposta alla nostra? Se è fuori dalla nostra “morale” e dalle nostre “regole”? Nei fatti l’Europa non sa che pesci pigliare, non sa come reagire, come dialogare con ciò che sfugge alla razionalità europea. È utile telefonare se chi risponde dall’altra parte della cornetta è sordo? Così, invece di imparare dai propri errori e trarre qualche buona lezione per il futuro, la colpa quasi subito diventa, è… di altri.
Terzo elemento di sofferenza. Il fatto che l’Europa dell’Ovest, di cedimento in concessione, di disattenzione in connivenza, ha contribuito ad allevare il Minotauro e il Minotauro si è avventato sull’Ucraina, uccidendo gli ucraini, prime vittime. E ora va destabilizzando non solo l’Europa del Centro-Est ma l’Europa tutta, con effetti a catena in Asia quanto in Africa.
Non avrei scritto questa breve nota se non avessi percepito il profondo malessere di alcuni amici ucraini, e anche una certa loro malinconica stanchezza all’impari lotta di idee nella quale si trovano volente o nolente invischiati.
Al riguardo mi ha molto colpito la recente testimonianza del saggista, critico letterario, politologo di Kyïv Mykola Riabchuk che di ritorno da Stoccolma raccontava in un incontro pubblico a Varsavia, tra l’altro, le sue esperienze europee e americane (vedi a 42’25 dall’inizio fino a 49’35 e poi da 1:05’20 fino a 1:12’20).
Mykola Riabchuk è un autore che da anni riflette sulle aspirazioni europee e le realtà euroasiatiche dell’Ucraina, sulla condizione post-sovietica del suo paese, dove si mescolano ortodossia, nostalgia dell’URSS e altre contraddizioni, sulle identità e i dilemmi degli ucraini. Nel suo profilo Facebook a un certo punto fa riferimento a – cito – “un ottimo servizio di NBC News su Odessa, con un leitmotiv chiaro e convincente: «L’identità di Odessa era un tempo una domanda sfocata e complicata, ma ogni missile russo che colpisce la città dà ai suoi abitanti una risposta più chiara: Odessa appartiene all’Ucraina e all’Europa» (Odesa’s identity was once a blurry and complicated question, but each Russian missile that hits this city makes the answer clearer for its people: Odesa belongs to Ukraine and Europe)”.
Tra i libri di Mykola Ryabchuk segnalo il recente: Лексикон націоналіста та інші есеї (Lessico nazionalista e altri saggi), Kyïv 2021.
Dalla presentazione: “Questa raccolta di saggi giornalistici è una visione approfondita e lungimirante del passato, presente e futuro dell’Ucraina negli aspetti politici e culturali. L’autore descrive i fenomeni delle realtà ucraine, in particolare analizza le piazze dell’Ucraina (2004 e 2013), considera la crisi dell’élite ucraina, la crisi di identità degli ucraini (quelli per nazionalità e/o cittadinanza), e dettaglia l’impatto della cortina di ferro dell’URSS novecentesca sulla cultura e sulla letteratura. La maggior parte di questi saggi è stata pubblicata su periodici, il più delle volte in inglese e ucraino, a volte in polacco e tedesco, e talvolta in lingue esotiche come il farsi, il turco e il catalano. L’autore ha preparato tutte le versioni ucraine [di questa edizione] con la speranza di un effetto sinergico di esperienze anche personali raccolte sotto un unico incarto, con la speranza di risvegliarsi dal sogno delirante sovietico, che non si è ancora dissipato [Il libro è uscito nel 2021]. Per una vasta gamma di lettori”.
Sul “Lessico nazionalista” di Mykola Ryabchuk vedi il commento di Bohdan Ben, nella quale il recensore sostiene – cito e traduco – che: “L’assenza di solidarietà repubblicana e una debole auto-associazione con lo Stato ucraino sono le ragioni per cui l’Ucraina ha ancora bisogno di tempo per portare a termine la propria Rivoluzione di Velluto. Tali carenze sono la conseguenza del lungo stato coloniale dell’Ucraina, sia sotto l’impero russo che sotto il successivo impero sovietico, spiega Riabchuk. Il postcolonialismo è il pensiero che utilizza nei confronti dell’Ucraina. La sua osservazione più importante è la distinzione tra due Ucraine: la Piccola Russia coloniale e la moderna Ucraina indipendente”.
(Sul tema dell’Ucraina “coloniale” vorrei tornare presto su Poli-logo con maggiore dovizia di analisi).
Di Mykola Ryabchuk si possono leggere anche i tre saggi sull’identità (uno scritto del 2013).
Inoltre, si possono trovare interessanti osservazioni sulla storia delle relazioni russo-ucraine in questa sua recente riflessione che ripercorre le vicende ucraine dal 1991: Making Sense of Ukraine: From the ‘nowhere nation’ to the ‘linchpin of European security’ (sulla rivista online “Kultura Enter”, 04-06-2022).
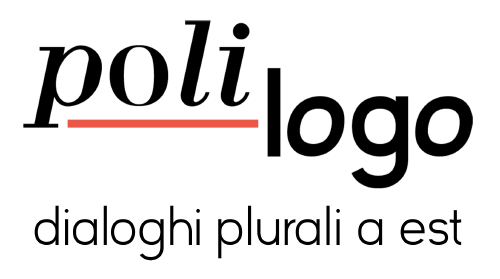
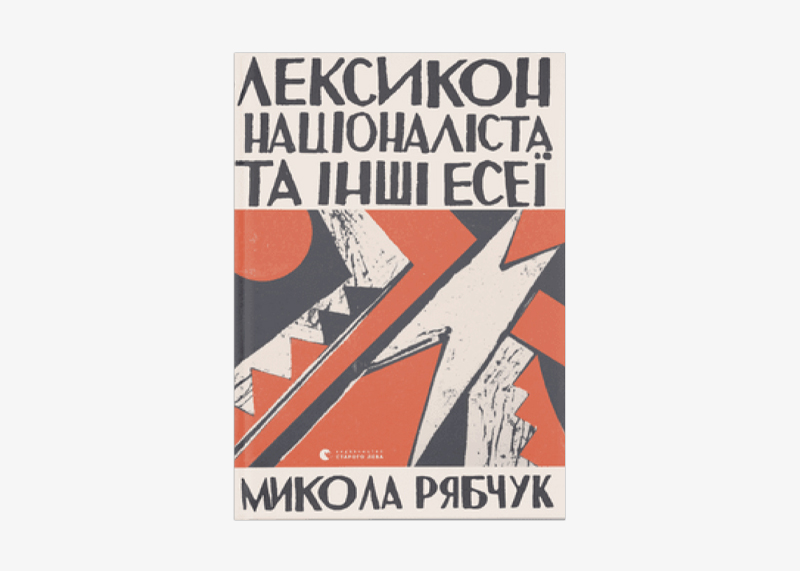
1 Commento. Nuovo commento
ho letto con grande interesse. Concordo pienamente con le amare considerazioni di Paolo Morawski sulla cecità di molti, troppi intellettuali italiani nei confronti dell’imperialismo russo. Peccato che il libro di Ryabchuk non sia stato ancora tradotto in italiano.