Una donna forte tra Seconda guerra mondiale e lotte per l’indipendenza
di Marta Nykytchuk
Immagine di copertina.
Nella propria storia familiare, ognuno di noi può sostenere di aver avuto un parente che ha combattuto, anche nel suo piccolo, a favore della liberazione della propria patria dal nemico. Considerando l’odierna guerra che tormenta l’Ucraina, la storia sembra ripetersi o forse non si è mai conclusa? Oppure questo conflitto segna il momento decisivo per imprimere una svolta epocale alla lotta di liberazione degli ucraini che si snoda da decenni, se non da secoli? E’ occasione comunque per rendere omaggio e ridare orgoglio a quei volti del passato, quelle persone “normali” che al loro livello hanno fatto il possibile per la causa nazionale rischiando la vita e la vita delle loro famiglie. Il desiderio di poter crescere i propri figli in uno Stato in cui non bisogna nascondersi per parlare la propria lingua e praticare la propria cultura in alcune persone è indubbiamente più forte della paura dei lavori forzati, della fame, degli abusi e della morte.
Nella foto: la giovane Mariya Petrushevyč-Yatsyshyn (Петрушевич – Яцишин Марія) nata il 23 giugno del 1924 e deceduta il 1° luglio del 2000.
Mariya fa parte di quella generazione di donne che affrontarono dure prove: l’essere strappate con forza dalla propria famiglia, il confrontarsi con una lingua completamente nuova e imposta (il tedesco, il russo), avere paura, fame, sete, subire svariati maltrattamenti, conoscere una forzata solitudine. La famiglia Petrushevyč-Yatsyshyn era numerosa: Mariya, le sue due sorelle Anna, Olga, e i tre fratelli Mykola, Levko (l’unico riuscito a scappare in Canada durante la guerra) e Stefan. Quando nel 1939 i tedeschi invadono e occupano la metà occidentale della Polonia, Mariya abita nella parte polacca orientale, a Sokal’ (Сокаль) un piccolo comune che si trova nella regione di Leopoli, allora Lwów polacca. La regione, come tutta la parte orientale della Polonia rinata alla fine della Prima guerra mondiale, è invasa nel 1939 dai sovietici e da loro annessa alla Repubblica Sovietica Ucraina. La Lwów polacca cambia in L’vov russa e L’viv ucraina. Ciononostante, Mariya a scuola continua a studiare in polacco, una lingua che lei già conosce bene per ragioni familiari, mentre a casa si comunica in ucraino. Poi, nell’estate del 1941, i tedeschi invadono anche la parte orientale dell’ex-Polonia già divenuta Ucraina sovietica. Il Reich avanza e le forze sovietiche si ritirano. Quelle terre ucraine saranno tedesche fino al 1944.
———-
Composizione delle nazionalità nella Piccola Polonia orientale secondo una mappa polacca del 1919. In considerazione degli enormi spostamenti demografici legati alla Prima guerra mondiale, alle devastazioni e alla mancanza di censimenti aggiornati della popolazione, la cartografia poteva basarsi solo su stime. La presenza maggioritaria polacca è segnata in rosso. Come si vede la regione intorno a Leopoli (Lwów) è tra le due guerre mondiali a macchia di leopardo, fonte.
La duplice invasione della Polonia: il 1 settembre 1939 il Paese è attaccato da ovest e occupato dalla Germania, il 17 settembre 1939 è attaccato da est e occupato dall’URSS, fonte.
Territori già polacchi tra le due guerre annessi nel 1939 alla Repubblica Socialista Sovietica Lituana, alla Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa e alla Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, fonte.
Trasformazioni territoriali dell’Ucraina (1922-1954). Nel 1939 l’Urss annette all’Ucraina quasi metà della Polonia d’anteguerra.
Organizzazione amministrativa (Reichskommissariat Ukraine) dell’Ucraina sotto dominio nazista (1941-1944), fonte.
———–
Conquistata e assoggettata l’Ucraina sovietica, a partire dalla fine del 1941 ai territori ora tedeschi i nazisti chiedono un Arbeiter, un lavoratore “volontario” per famiglia. Da ogni nucleo famigliare ucraino vengono prelevati i ragazzi, giovani e in salute, per essere spediti in Germania a sopperire alla penuria di manodopera, essendo gli uomini tedeschi massicciamente mobilitati nell’esercito e il Reich colpito da una grave crisi economica.
A soli diciassette anni Mariya – dato che i suoi fratelli sono troppo giovani e le sorelle, una è in età da marito e l’altra già sposata – si offre di partire lei volontaria in Germania. Come Ostarbeiter finisce presso una famiglia di agricoltori che aiuta quotidianamente nelle faccende domestiche. Rimane lì probabilmente fino a fine 1943 o agli inizi del 1944 (nessuno più ricorda la data esatta). Paradossalmente, la permanenza presso una famiglia tedesca le tornerà molto utile. Infatti, in Germania perfeziona la lingua tedesca di cui si servirà in seguito quando aiuterà i “banderisti” o i banderovtsy ucraini. Ma nel caso di Mariya sarebbe più esatto dire che darà aiuto agli ucraini che lottano per l’indipendenza del paese, non avendo lei niente a che fare con Stepan Bandera, certamente la figura più controversa della storia recente dell’Ucraina: eroe dell’indipendenza ucraina-criminale-fascista.
Finito il periodo lavorativo in Germania, Mariya fa ritorno in patria trovando una situazione di grande instabilità e confusione. Nell’ovest dell’attuale dell’Ucraina, come si è detto allora sotto dominio tedesco, combattono in clandestinità i nazionalisti ucraini, chiamati anche banderovtsy dal loro capo Stepan Andrijovič Bandera (1909-1959), risoluto leader dell’OUN-Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini all’Ucraina che il 30 giugno 1941 a Leopoli ha unilateralmente proclamato la restaurazione dello Stato ucraino contando sull’alleanza con la potente Germania nazista nella lotta contro l’Unione Sovietica. Annuncio del tutto vano perché non gradito a Berlino e non sostenuto dalle truppe naziste in avanzata verso l’interno dell’URSS. Nonostante molti ucraini avessero accolto come liberatori i tedeschi, nonostante l’autoproclamata Ucraina indipendente si fosse dichiara pronta a collaborare con il Reich e nonostante molti volontari ucraini già combattessero sotto comando tedesco, molto presto fu evidente che per i nazisti l’Ucraina era terra di conquista, da sfruttare, e gli ucraini altro non era che manodopera a buon mercato, da spremere senza ritegno in quanto come altri slavi “sotto-uomini”, “sub-umani” (Untermenschen). Così i tedeschi avevano effettuato arresti di massa di attivisti dell’OUN. Pertanto, Bandera nell’ottobre 1942 aveva fondato in Volinia un’organizzazione paramilitare, l’Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA). Obiettivo dell’UPA era la creazione di uno Stato ucraino indipendente e monoetnico (mono-nazionale). A tal fine, combatteva con le armi sia contro le truppe tedesche di occupazione (pur collaborando con esse in una certa misura, per esempio a livello locale), sia contro i partigiani polacchi (in Volinia, Podolia, Galizia), sia contro i partigiani sovietici (1943-1944), sia infine contro l’Armata Rossa e l’NKVD, la polizia politica staliniana. Da est, infatti, nel febbraio 1943 era partita la controffensiva sovietica che avrebbe portato l’Armata Rossa a liberare Kiev dai nazisti nel novembre 1943 e Leopoli nel luglio 1944.
Quando Mariya torna a casa il Paese, dunque, versa in una situazione a dir poco caotica e di estrema violenza. Suo fratello Stefan (Стефан) è membro dei nazionalisti ucraini. Milita nella fazione di Andriy Melnyk (1890-1964), più moderata rispetto a quella capitanata da Bandera. Per i combattenti indipendentisti del fratello Stefan, Mariya è “Marta”: usa quel nome in codice per non farsi riconoscere dalle persone esterne al gruppo, ma lo pseudonimo torna anche utile per capire chi fa parte del gruppo e chi no; solo i membri interni infatti sanno di dover usare quel soprannome. Il ruolo assegnato a Marta-Mariya è quello di aiutare il fratello Stefan e i suoi compagni durante i loro spostamenti dall’odierna Ternopil all’odierna L’viv (Leopoli). Si tratta di spostamenti difficili, lunghi (circa 150 km) e pericolosi poiché tutti rischiano come minimo la prigione. Grazie alla sua conoscenza della lingua tedesca, i nazisti ai blocchi di controllo non sospettano di lei e Marta-Mariya riesce a far passare i nazionalisti ai blocchi di controllo raccontando ai tedeschi appropriate false-verità sul proprio conto e quello degli altri nazionalisti; i quali da parte loro non la sospetteranno mai di intesa col nemico nazista anche perché da ex deportata in Germania non ha alcuna intenzione di collaborare con i tedeschi colonizzatori. Anzi, grazie a lei moltissimi resistenti e nazionalisti ucraini si salvano dall’arresto. Come al giorno d’oggi, molti soldati ucraini vengono aiutati dai civili, così fa lei fa con i Melnykivtsi (che vengono però definiti genericamente Banderivtsi).
A guerra finita, Marta-Mariya, prima del matrimonio e dell’arrivo della primogenita Irene (insieme nella foto qui sopra) continua a collaborare e dare assistenza a molti indipendentisti, una parte dei quali prosegue la lotta contro i polacchi in Polonia (nella nuova Polonia post-bellica); e un’altra parte cerca di opporsi in tutti i modi all’ennesima sovietizzazione dell’Ucraina passata nuovamente e interamente sotto il dominio di Mosca (fino al 1991). Numerosi resistenti si salvano dall’arresto e dalla prigionia, ma non lei. Il 3 marzo del 1953 le viene comunicato dalle autorità sovietiche di doversi urgentemente presentare all’ufficio dei passaporti per un semplice controllo dei documenti ed è quello che lei fa. Lascia Irene, la sua bambina, con il marito Mykhaylo Yatsyshyn (Михайло Яцишин) per recarsi all’ufficio dei passaporti – questo è l’ultimo ricordo che ha di sua figlia prima della prigionia. Camminando verso l’ufficio, viene improvvisamente fermata per strada da due uomini del KGB (agenti del Comitato per la sicurezza dello Stato), i quali, una volta appurato che non è armata, la spingono dentro una macchina e la portano via. All’uscita della macchina ci sono cinque uomini ad attenderla. La fanno veramente sembrare, come si diceva un tempo, una “vrag narodu”, una “nemica del popolo” che ha commesso chissà quali reati contro l’Unione Sovietica solo perché, anni prima, ha aiutato esponenti del movimento nazionalista. È una “nemica” perché “nemico” è/era il fratello Stefan, che il KGB ben conosce: è ricercato da tempo, nessuno sa se sia vivo o già morto.
I poliziotti del KGB fanno leva sul fatto che la sua bambina è rimasta a casa; quindi, le fanno una richiesta del tutto “meschina, astuta e insidiosa” (racconterà poi Mariya): le chiedono di collaborare con il KGB. Mariya è ben consapevole che quella per lei sarebbe l’unica via d’uscita, l’unica sua salvezza, ma con dignità rifiuta. A quel rifiuto, incomincia un lungo ed estenuante interrogatorio in cui le chiedono informazioni sul conto del fratello, sulla sua collaborazione con gli altri nazionalisti e fuggitivi ucraini. La minacciano, la maltrattano, fanno di tutto, ma Mariya non dice mai una parola pur rischiando la propria vita.
Marta-Mariya viene allora portata in prigione, dove una certa Shcherba Hanna (Щерба Ганна), una traditrice, testimonia contro di lei. Dopo tredici giorni di detenzione, il 16 marzo 1953, Mariya, nonostante la febbre, viene prelevata per – le si spiega – effettuare un riconoscimento. Fuori, ricorda, fa molto freddo. Il funzionario-responsabile esce con lei dalla macchina e, lasciandola in disparte, bussa a una porta. “Chi è?” si sente chiedere da dietro la porta d’ingresso. Il funzionario risponde: “i vostri”. Il portone si apre, colpo di scena: dall’interno sparano al responsabile e ai suoi collaboratori, tutti gli agenti muoiono sul colpo, crollano davanti allo sguardo incredulo di Mariya. Qualcuno allora l’agguanta urlandole le seguenti parole: “traditrice, hai portato i bolscevichi per ammazzarci?!” Mariya è legata, le coprono gli occhi per non farle vedere la strada, la portano in un bosco, non lontano da Kryvyj Rih. Nel bosco gli stessi nazionalisti la maltrattano e abusano di lei perché la credono una traditrice. Poi, una volta giunti in una casa-nascondiglio, Marta-Mariya cerca di chiarire la situazione, di spiegare a quegli uomini che sono dalla sua stessa parte, che lei è stata rapita dal KGB, ma non ha mai detto nulla, nemmeno una parola. Gli uomini son convinti, le dicono allora che può considerarsi fortunata, che l’hanno salvata a forza dai bolscevichi, ma solo perché è la sorella di un ben noto nazionalista, Stefan (neanche loro sanno se e dove sia). Dicono di poterla aiutare a superare il confine polacco, ma in cambio la vogliono costringere a sistemare una certa questione con alcune persone assai importanti, persone con le quali suo fratello era in contatto. Marta-Mariya, purtroppo, non conosce personalmente quelle persone e per di più è ricercata. Allora la fanno uscire dal nascondiglio ma durante il tragitto i suoi accompagnatori vengono a loro volta uccisi da altri agenti del KGB. Ecco: Mariya è stata ritrovata, nuovamente picchiata, riportata in prigione.
Tra il 12 ed il 13 maggio del 1953 Mariya Petrushevyč-Yatsyshyn è giudicata colpevole dal tribunale per i crimini che le vengono attribuiti e, secondo la legge, le vengono dati 25 anni di prigionia. La sua unica richiesta è quella di rivedere la propria bambina, richiesta che fa ridere gli uomini che la scortano, che le rispondono con un crudele: “non la vedrai mai più”. Affermazione che si rivelerà per fortuna del tutto erronea.
Da condannata, Mariya è malnutrita, pesa 38 kg, ma grazie a cure mediche si riprende. Le viene assegnato un numero personale che si ricorderà fino alla fine dei suoi giorni: B-2-472 (ogni prigioniera ha il proprio numero con cui viene chiamata). Presto la spostano in un campo di lavori forzati in Siberia. In una stanzetta fredda dormono circa trenta donne, dormono per terra, per riscaldarsi si accovacciano l’una accanto all’altra. La mattina bevono acqua bollente, mangiano cibo andato a male. L’acqua bevuta di mattina risulta insufficiente, per bere iniziano allora a sciogliere la neve. Di solito d’inverno le detenute lavorano in un bosco, nel periodo estivo raccolgono patate.
Le detenute sono poi spostate ai lavori forzati a Karlag, uno dei più grandi gulag sovietici situato nel territorio della regione di Karaganda nell’allora Repubblica Socialista Sovietica Kazaka. Il campo, attivato nel 1931, occupa un posto speciale nella storia delle repressioni sovietica. Nel corso della sua esistenza, a Karlag è transitato circa un milione di persone, ma poiché gli archivi di Karlag sono rimasti segretati, è impossibile fornire il numero approssimativo delle sue vittime. Ciò che è certo è che il 27 luglio 1959 il campo viene chiuso: allora non ha praticamente più prigionieri politici.
A Karlag i prigionieri sono costretti a dedicarsi alla produzione agricola, a costruire un sistema di trasporto ferroviario, a lavorare nell’industria mineraria e nell’edilizia. Il tasso di mortalità durante il trasporto delle persone al campo Karlag risulta molto alto e i cadaveri sono sepolti lungo i binari della ferrovia. Tutti i fascicoli dei prigionieri morti vengono distrutti. Impossibile, dunque, conoscere il numero esatto di persone che sono passate di lì.
Durante i suoi ultimi anni di prigionia, Mariya si fa forza collaborando con altre donne, si sostengono a vicenda per non dimenticare, con la speranza di rivedere le proprie famiglie e il proprio paese libero da libere. Nel 1952 le autorità carcerarie iniziano a fare il controllo dei “numeri”. Coloro che risultano non riconfermati/e come prigionieri/e politici/che possono tornare a casa. Nel 1957, qualche tempo prima della chiusura di Karlag, Mariya è rilasciata. Le danno 24 ore di tempo per tornare a L’viv, prendere i suoi effetti personali e lasciare la città nella quale le viene proibito di tornare. Suo marito Mykhayko la attende con la primogenita Irene. La bambina ora ha quasi sette anni e non riconosce la madre. A “quella signora” che le viene incontro Irene risponde di avere “una mamma molto più bella”. Col tempo si calmano le acque e dopo qualche anno, nel 1958, nasce la secondogenita di Mariya, Oksana.
Mariya ha raccontato di aver scritto le proprie memorie durante gli anni della prigionia, pagine che contenevano date, posti precisi e anche i nomi di tutti coloro che l’hanno giudicata, vessata, seviziata. Ha provato a pubblicare le sue memorie per testimoniare e documentare pubblicamente ciò che molte persone subivano in silenzio. Era pronta a parlare. Purtroppo, ciò non è stato possibile perché le persone che lei nominava nei suoi scritti, allora erano ancora in vita e nessun editore era pronto a pubblicare scritti che correvano il rischio di possibili denunce. Così le sue memorie non sono mai state edite e molte pagine si sono perse tra traslochi e spostamenti vari.
——-
——-
Mariya ha vissuto una vita lunga ed è riuscita a conoscere anche la sua prima pronipote, nonché nipote della primogenita Irene la cui figlia Yuliya ha dato il nome “Marta” – che poi sarei io – per non dimenticare il nome di battaglia utilizzato da Mariya ai tempi del suo impegno a fianco dei nazionalisti indipendentisti ucraini.
Nel ricostruire la storia di Mariya-Marta Petrushevyč-Yatsyshyn alcune informazioni sono state riprese dal libro di Olga Žulkovs’ka, Non abbiamo un briciolo di falsità dietro di noi. Anche Olga Žulkovs’ka fa parte di quella generazione di donne che hanno partecipato alla lotta di liberazione contro l’occupazione russo-sovietica, e ha personalmente conosciuto Marta-Mariya e altre donne di cui ha trascritto talune storie per non lasciarle nell’oblio. Anche il suo libro, dunque, che prende il titolo da una poesia di Taras Ševčenko e appartiene alla biblioteca di famiglia, è stato scritto per non dimenticare le persone comuni che hanno contribuito, in un modo o nell’altro, al difficile lavoro di liberazione del popolo ucraino dall’Unione Sovietica. Altre informazioni qui riassunte provengono dai diretti racconti della bisnonna Mariya, chiamata anche affettuosamente in famiglia “babul’ka”, un vezzeggiativo che le è stato attribuito dalla sua prima nipote Yuliya (mia madre), figlia della primogenita Irene (mia nonna). “Babul’ka” sarebbe un termine inventato e derivante dalla modifica del termine “bisnonna” ovvero “прабабуся” traslitterato “prababusya”.
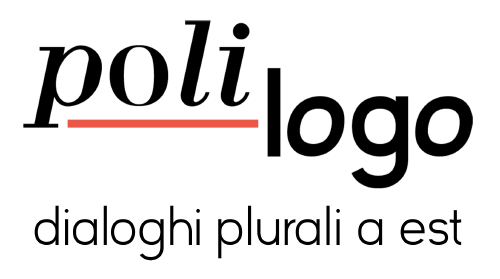











1 Commento. Nuovo commento
Solo raccontando queste storie di persone singole e singolari si può capire davvero la cosiddetta Storia. Il resto è prevalentemente ideologia.
Dico questa banalità perché forse c’è sempre bisogno di ricordarla.